Medicina nucleare, così la PET
oltre ai tumori riesce a vedere anche le infiammazioni
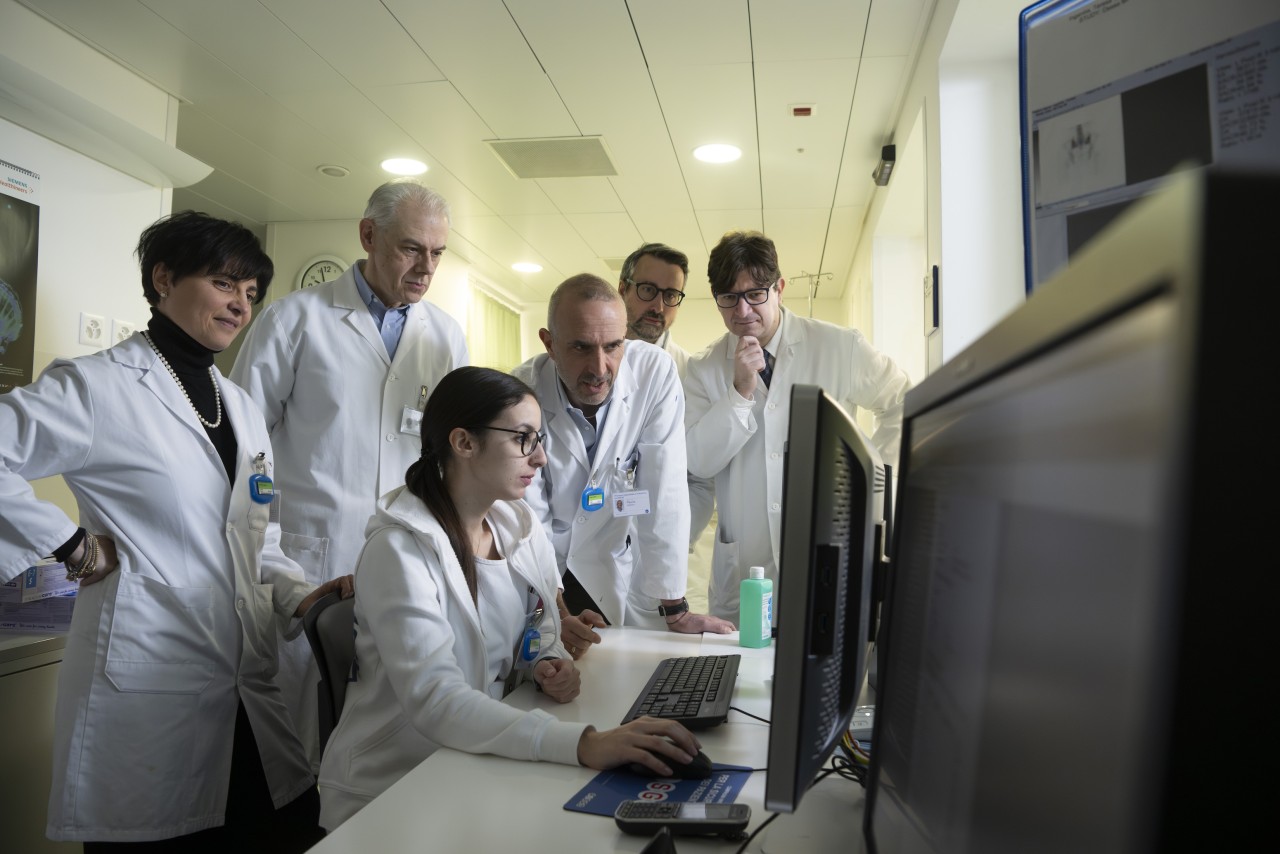
Esperti a confronto il 26 febbraio al Campus est per il Simposio organizzato dall’EOC. Le nuove tecniche permettono di allargare lo sguardo a numerose patologie, ma non sempre i medici le prescrivonodi Paolo Rossi Castelli
Occhi puntati, il 26 febbraio al Campus est USI-SUPSI di Viganello, sulla Tomografia a Emissione di Positroni, una tecnica diagnostica importante, ma dal nome difficile per i non addetti ai lavori, in sigla PET (spesso presente nei "percorsi" per arrivare all’identificazione dei tumori: in particolare, delle metastasi). La PET sarà al centro del Simposio di Medicina Nucleare della Svizzera Italiana, organizzato dall’Ente Ospedaliero Cantonale con il patrocinio dell’USI e dell’Ordine dei medici del Canton Ticino, giunto quest’anno alla seconda edizione (ora di inizio, le 16.30, nella Sala polivalente, con ingresso libero). Esperti svizzeri, ma provenienti anche dall’Italia, racconteranno in che modo questa tecnica può aiutare a identificare, con una precisione prima impossibile, anche altre patologie, oltre ai tumori: soprattutto, le infiammazioni e alcuni tipi di infezioni.
Come funziona la PET? Riesce a individuare le zone dell’organismo in cui vengono consumate alte quantità di glucosio (la molecola principale che le cellule utilizzano per ottenere energia), e questa è una caratteristica tipica dei tessuti cancerosi, con un metabolismo iper-attivo, ma anche di quelli infiammatori. Così vengono “scovate” masse tumorali, o focolai infiammatori/infettivi, che altrimenti sarebbero invisibili. Naturalmente occorrono attrezzature sofisticate e una grande esperienza per distinguere la natura dei diversi tessuti “avidi” di zucchero, che la PET mette in mostra. È un progresso diagnostico continuo, certificato da numerosi studi internazionali, che permette di curare meglio i pazienti, e in modo più tempestivo, attraverso un uso adeguato della PET. Ma non sempre queste potenzialità vengono percepite dagli stessi medici (soprattutto, dai medici di famiglia, dai cardiologi, ortopedici, infettivologi e reumatologi), che in molte occasioni tendono a rimanere ancora legati agli esami diagnostici più “classici” (ecografie, TC, e così via), a volte per una conoscenza incompleta dei vantaggi e delle potenzialità di questo metodo diagnostico.
Il Simposio organizzato dall’Ente Ospedaliero Cantonale vuole proprio portare chiarezza su questi temi. «È vero che la PET è una tecnica più complessa e costosa rispetto a quelle tradizionali - spiega Giorgio Treglia, viceprimario della Medicina nucleare all’EOC - ma se si considera l’impegno finanziario in modo più ampio, si vede che il costo complessivo per curare i malati diminuisce, in molti casi, tramite la PET, perché una diagnosi più precisa significa anche una terapia più efficace e mirata, che riduce spesso la necessità di nuove cure, ricoveri, esami. In più - continua Treglia - grazie alla PET (o, meglio, alla PET-TC: una tomografia a emissione di positroni, abbinata a una tomografia computerizzata) è possibile individuare le cause delle cosiddette patologie occulte, che provocano alcuni tipi di sintomi, a partire dalla febbre cronica, o fanno innalzare i marcatori dell’infiammazione nel sangue, senza che però sia possibile, per i medici, identificarne l’origine».
La PET-TC è in grado di identificare anche le vasculiti dei grandi vasi arteriosi, le patologie infettive cardiovascolari (endocarditi, infezioni di protesi cardiache o vascolari), le infezioni vertebrali e le patologie infettive o infiammatorie di interesse ortopedico o reumatologico: tutti problemi spesso difficili da decifrare.
Un numero crescente di ricerche dimostra l’efficacia “allargata” della PET, e lo stesso Treglia ha partecipato all’estensione di linee guida internazionali sull’argomento, che sono apparse poche settimane fa sull’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, la principale rivista europea di Medicina Nucleare.
IL POTERE DEI RADIOFARMACI - Ma, più in dettaglio, come agisce la PET? Al paziente viene somministrato per via endovenosa un radiofarmaco, che contiene un isotopo debolmente radioattivo. Uno dei più utilizzati a scopo diagnostico è il fluorodesossiglucosio (in sigla FDG), cioè una molecola di glucosio modificato (per renderlo, appunto, radioattivo). Questo “tracciante” si accumula, come dicevamo, nelle cellule che consumano più energia, come quelle tumorali, o in quelle dell’infiammazione. Il radioisotopo rilascia positroni (particelle con carica positiva) che, quando incontrano elettroni all’interno dell’organismo, si annichilano (questo il termine tecnico), generando due fotoni gamma che viaggiano in direzioni opposte. Gli scanner PET contengono sensori specializzati, in grado di rilevare questi fotoni gamma. Un apposito software elabora poi i dati, e crea immagini tridimensionali del metabolismo cellulare.
NECESSARIO UN CICLOTRONE - Per produrre i radiofarmaci occorre una speciale, e complessa attrezzatura, il ciclotrone (un acceleratore di particelle). In Ticino non esistono macchine di questo tipo, e i radiofarmaci arrivano, ogni mattina, da Zurigo, tramite un apposito furgone, che li consegna all’ospedale regionale di Bellinzona e a quello di Lugano, dove sono presenti due PET-TAC. Questo servizio funziona molto bene, da anni. Solo quando l’autostrada è bloccata, o comunque quando lunghe code rallentano fortemente il viaggio (ma nelle prime ore della mattina succede raramente), da Zurigo devono mandare una seconda spedizione, perché i radiofarmaci hanno una “durata” radioattiva (emivita) così bassa, per evitare danni all’organismo, che dopo brevissimo tempo decadono. Nulla a che vedere con le radiazioni di Chernobyl!
La PET rientra in quella che viene chiamata medicina nucleare, ma i procedimenti che vengono utilizzati appartengono a un altro “universo”, rispetto a quello delle centrali per produrre energia elettrica, o - inutile dirlo - a quello delle armi nucleari.
A volte la medicina nucleare viene confusa con la radiologia (in effetti, per chi non è un esperto della materia, la differenza non è così semplice da delineare). «La medicina nucleare - ribadisce Gaetano Paone, primario della Medicina Nucleare EOC - usa sostanze radioattive per diagnosi e terapie, che generano radiazioni, ben diverse dai raggi X utilizzati per la TC (che sono onde elettromagnetiche ad alta energia), o dai campi magnetici della risonanza magnetica, dalle onde sonore dell’ecografia e dalle altre tecniche usate dai radiologi».
Le diverse attrezzature portano, naturalmente, a risultati differenti: TC, risonanza magnetica ed ecografia permettono di mostrare in modo sempre più dettagliato la struttura, la densità e le dimensioni dei tessuti esaminati. «La medicina nucleare, invece - dice Paone - è in grado di mostrare i processi fisiologici, e quelli patologici, prima che determinino alterazioni poi visibili con l’”imaging” radiologico».
Già negli anni ’20 del secolo scorso Marie Curie aveva ipotizzato l’idea di utilizzare sostanze radioattive per curare i tumori. «Ma solo a partire dagli anni ’60 - continua Paone - quest’idea è stata realmente messa in pratica, soprattutto per curare la tiroide con lo iodio 131. Poi, dagli anni 2000 in avanti, con lo sviluppo della PET, la medicina nucleare ha avuto un fortissimo sviluppo anche per diagnosticare e curare altre patologie. E la Svizzera, e il Ticino, sono sempre stati in prima linea. All’EOC, oltre ad attrezzature d’avanguardia, abbiamo anche un’intensa attività di ricerca, con studi-pilota avviati soprattutto sui tumori prostatici e su quelli neuroendocrini. Il futuro prossimo sarà nella teragnostica (diagnosi più terapia), già attiva, comunque, qui in Ticino da alcuni anni: l’uso di radiofarmaci, cioè, per raggiungere in modo sempre più preciso le cellule tumorali e distruggere solo quelle, con danni limitati ai tessuti sani».
