Partono dal Cardiocentro
nuove linee-guida internazionali
per i pazienti con uno "stent"
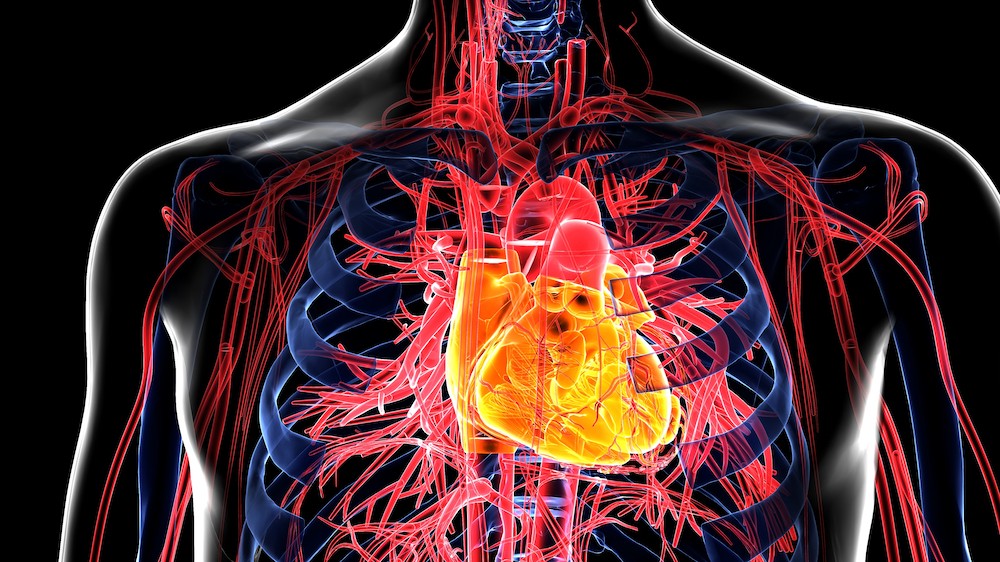
Sul New England Journal of Medicine i risultati di uno studio firmato, come primo autore, da Marco Valgimigli, viceprimario dell’istituto cardiologico EOC. Attenzione puntata sugli interventi alle coronariedi Giacomo Perruzza
Partono anche dal Cardiocentro Ticino - e in particolare dal viceprimario Marco Valgimigli, in collaborazione con un folto gruppo di ricercatori sparsi in Europa, Asia, Sud America e Australia - nuove, importanti linee guida per i pazienti a cui è stato inserito uno stent coronarico (una piccola protesi metallica capace di mantenere aperte le arterie coronarie, appunto, che portano sangue al muscolo cardiaco), con un intervento chiamato di angioplastica. Le nuove indicazioni riguardano soprattutto i pazienti che sono ad alto rischio di sanguinamento, perché hanno altre patologie che si sovrappongono a quella propriamente del cuore. In queste persone il dilemma clinico è per quanto tempo va prolungata una terapia che è necessaria dopo l’intervento (definita doppia terapia antiaggregante, in sigla DAPT), ma che amplifica notevolmente anche il rischio di sanguinamento. I ricercatori hanno dimostrato che è sufficiente somministrare la DAPT solo per un mese, e non per i 3-6 mesi previsti finora dai protocolli. E i risultati di queste studio, presentati recentemente al congresso della Società europea di cardiologia, sono stati pubblicati dal New England Journal of Medicine, uno dei più prestigiosi giornali scientifici al mondo nel settore medico. Valgimigli è il primo autore e ha disegnato, come si dice in gergo tecnico, l’impostazione dello studio stesso.
«Quando si deve trattare un restringimento delle coronarie, si finisce sempre per impiantare uno stent – spiega Valgimigli. - Questa piccola protesi permette di mantenere aperto un vaso in corrispondenza di un blocco che si può formare al suo interno, e che rallenta il flusso del sangue, rischiando di fermarlo del tutto. Per evitare che lo stent si richiuda è necessario associare all’impianto anche la DAPT, che scioglie un po’ il sangue, rendendolo più liquido. Questa terapia - prosegue l’esperto - consiste nell’associazione di due farmaci: uno è l’Aspirina, l’altro è un medicinale con un meccanismo deputato anch’esso a sciogliere il sangue (Clopidogrel, Ticagrerol, Prasugrel). Fino a circa un anno fa, a questi pazienti veniva prescritta l’assunzione di un duplice antiaggregante per almeno un anno; poi una serie di studi ha mostrato come il rischio marcato di sanguinamento che la terapia comportava, a fronte dei piccoli benefici sull’efficacia, ne raccomandasse una durata più ridotta, da 3 a 6 mesi». Ora l’indicazione è, invece, come dicevamo, solo di un mese.
Questa riduzione temporale è importante, perché la somministrazione della terapia antiaggregante comporta una serie di disagi per i pazienti, che durante il trattamento non possono, ad esempio, sottoporsi a esami diagnostici né ad altri interventi chirurgici, e non possono nemmeno andare dal dentista, perché il rischio di sanguinamento è alto. I farmaci della DAPT, infatti, sciolgono il sangue che arriva al muscolo cardiaco, ma anche in tutte le altre parti del corpo, e questo può causare sanguinamenti. Alcuni sono banali, come epistassi o piccoli abbassamenti dell’emoglobina; altri, invece, fanno sì che il paziente ritorni in ospedale per problemi gravi, come perdita di sangue dal tubo gastroenterico o dai polmoni. Ovviamente, non tutte le persone hanno lo stesso rischio di sanguinare. Alcune categorie appaiono particolarmente esposte, per loro caratteristiche intrinseche, o per farmaci che devono prendere anche in seguito ad altre malattie: sono soprattutto i pazienti con malattie croniche reumatiche, i pazienti oncologici, le persone con una malattia primitiva del sangue, oppure i pazienti con un pregresso ictus cerebrale, o con emoglobina bassa e quindi già anemici di base, o con insufficienza renale. Queste persone hanno un aumentato rischio di sanguinare spontaneamente, e i problemi possono aumentare, naturalmente, se vengono trattati per lunghi periodi con la terapia antiaggregante».
Valgimigli e gli altri ricercatori hanno provato a ridurre, con successo, la durata della terapia antiaggregante proprio in questi pazienti. «Abbiamo comparato un mese di DAPT - spiega Valgimigli - con quello che si chiama "standard of care", la terapia standard, ovvero una durata di sei mesi. Per la nostra indagine abbiamo reclutato oltre 4500 pazienti, provenienti da 140 centri in 30 Paesi. Lo studio, di fatto, ha dimostrato in maniera molto semplice che riducendo la DAPT a un mese non si ha nessun prezzo da pagare per quanto riguarda il rischio che gli stent si richiudano, o che ci siano eventi avversi (morte, infarto, ictus, che sono poi quello che si vuole evitare con questa terapia). Al contrario, è stato dimostrato che vi è una marcata riduzione del sanguinamento. In buona sostanza, lo studio ha dimostrato che il nuovo "standard of care" deve essere un mese di terapia antiaggregante».
Un solo mese di DAPT è stato inoltre associato a un minor numero di ictus, sia ischemici che emorragici. «Questa risposta è arrivata in maniera piuttosto inaspettata, anche per me – commenta Valgimigli. – È una tendenza che sta più volte venendo osservata nella letteratura scientifica e corrisponde al principio less is more: siamo arrivati a un punto, cioè, in cui paradossalmente dando meno terapia, o terapia di minor durata, non solo si riducono i rischi di complicanze della terapia stessa, ma anche gli eventi che la terapia dovrebbe inibire. Alla luce di queste evidenze non c’è nessun motivo per prolungare la DAPT. E questa è una sorta di liberazione per il paziente».

